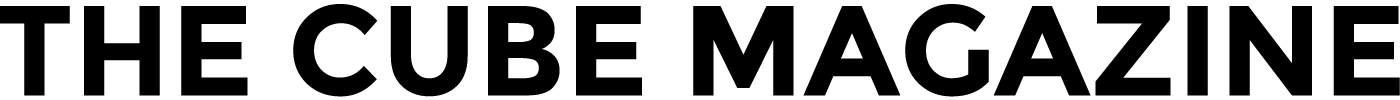@mary ray
@mary ray @mary ray
@mary rayLo scrittore svedese Hjalmar Emil Fredrik Söderberg racconta la nostalgia di un tempo passato. Un memoir di sogni e immaginazione, ma anche di dolore.
“Ascolto cadere la pioggia
Qui solo, nel buio totale,
martella battente ogni goccia
sul bordo del davanzale.
D’angoscia il mio petto si strugge
Il fiato non trova più tregua
È la mia giovinezza che fugge,
goccia a goccia scorre e dilegua.”
Hjalmar Emil Fredrik Söderberg “La giovinezza di Martin Birck”
Chi ricorda la giovinezza o la sta attraversando dovrebbe leggere “La giovinezza di Martin Birck”, poiché è un memoir, con qualcosa di catartico.
Lo ha scritto un sensibile interprete della crisi di fine Ottocento, e fra le maggiori figure della letteratura svedese Hjalmar Emil Fredrik Söderberg (Stoccolma 1969 – Copenanghen 1941) e lo ha pubblicato in Italia Iperborea, con la traduzione di Massimo Ciaravolo.
Si sa non è questo il primo resoconto sul passaggio tra adolescenza e maturità, basti pensare “Il giovane Holden” scritto da J. D. Salinger e “Noi” di Richard Mason, un romanzo sull’amore e sulla crudeltà, sull’irresponsabilità dell’adolescenza, quando tutto è assoluto e ad ogni passo sembra che la vita intera sia in gioco.


“La giovinezza di Martin Birck” è una straordinaria testimonianza della vita che si mescola con la letteratura, un libro estremamente flemmatico, nel senso che lo anima una lucida pacatezza.
Ciò che colpisce sopra ogni cosa, in Söderberg, rispetto ai vari precedenti libri possibili, è questo particolare registro di scrittura.
Gli accenti sono amari, ma al contempo hanno una qualità mite e distesa.
Un andamento morbido, regolare, anti-enfatico e privo di compiacimenti stilistici, conduce il testo in dimensioni espressive elevate.
Una precisione verbale mirabile, e una sorta di culto dell’onestà nella confessione delle sofferenze, percorrono ogni pagina del racconto.
Le parole riempiono di significato rigenerativo il pessimismo di Martin Birck che ama la sua famiglia, che spera di diventare un poeta, e si augura un amore infelice e un posto all’Accademia Svedese, o di vivere da eremita e scrivere per aprire gli occhi all’umanità sul senso della vita e la verità.

Ma quale è la verità? Martin Birck la cerca, mentre tenta di partecipare ai rituali dei suoi compagni borghesi, nel lavoro nella pubblica amministrazione, nelle serate all’opera o nelle bevute di grog al bar.
Ma “cosa ne abbiamo fatto della vita?” si ripete. Come può trovarsi a suo agio in una società in cui le donne sono represse, costrette a proteggere la loro “virtù”, o macchiarsi della sua perdita, con la compiacenza dei gentiluomini.
E come può credere nello stesso dio di sua madre, tutore dell’ordine borghese, e nel suo “cristianesimo per tradizione e consuetudine”.
Söderberg cerca luce e tratteggia un personaggio che sente lo stesso scollamento tra l’io e la vita, quella che si può trovare solo fuori dalle gabbie delle convenzioni e del perbenismo.

Söderberg legge “Malte Brigge” di Rilke e sente una pena immensa per l’orribile chiacchiericcio dell’universo che si era riversato nelle orecchie di Martin Birck. Tramite l’immersione nella letteratura Söderberg crede di poterlo ascoltare. Osserva i sogni, e le sue composizioni poetiche. Indaga l’aggressiva tristezza, che emanano i personaggi incontrati nelle passeggiate monotone nei boulevard. Parla di figure femminili fino alla scoperta di una possibile felicità minore, da vivere in clandestinità nelle notti di Stoccolma. E in questo richiamo si percepisce una nota estatica, un impulso di tenerezza smisurata, che ci s’incolla addosso.
Di Alberto Corrado