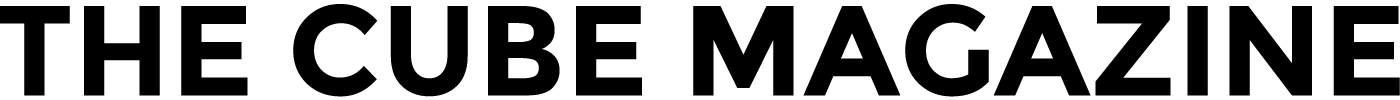Pur nei loro diversi ruoli psicologici e nelle diverse posizioni di potere, tutti i personaggi del Don Carlos sono alla fine dei perdenti. L’opera di Giuseppe Verdi apre la stagione della Scala, nella ricerca ostinata del presente dove la politica e i fanatismi dominano la scena.
“Ella giammai m’amò! Non quel cor chiuso è a me
Amor per me non ha!….”
Filippo Atto terzo quadro primo de “Don Carlos” di Giuseppe Verdi
La gravosità del colore nero, in sintonia con i drammatici fatti di cronaca e con il nostro presente, penetra in questo “Don Carlos” che ha aperto la stagione scaligera a Milano, tra roghi infuocati dell’Inquisizione, spietatezza della politica, fanatismi religiosi e i triangoli ossessivi dell’amore.

Cosi crudelmente decapitato dell’atto di Fontainebleau, il “Don Carlos” nella nuova edizione in quattro atti, come si legge sul frontespizio della versione della Scala 1883-1884, si apre in media res, nel Chiostro del Convento di San Giusto. Non c’è più luce simbolica, nemmeno quel baleno filtrato da una natura innocente, che per un attimo pareva riscattare le tinte fosche, da tutto quello nero di pece spagnoleggiante e del drammatico amore di Don Carlos per Elisabetta.

Il Don Carlos si apre così come una vanitas in musica, scurori da pittura tenebrosa post-caravvagesca, mesti cori conventuali, ceri fumiganti e sinistro languire d’ombre, che tramano di luttuosa tensione l’annerita volta della cripta.
Anche il messaggio filosofico è radicale, metafisico, quasi Apocalittico, quello di Carlo V che voleva regnare sul mondo “L’orgoglio immenso fu l’errore suo profondo”. Il Sole troneggiante del sommo Imperatore viene a spegnersi in questo occaso di vile cenere mortale.

Un’opera che si apre sulla negatività, che si affaccia pericolosamente sulla visione schopenhaueriana della vita, come eros, orgoglio, mentre sullo sfondo, nel labirinto inchiostrato delle segrete, il respiro spettrale di Dio, che non sa perdonare.

Forse è vero, chiusa tra le due scure quinte dell’Escorial, che tanto aveva suggestionato Giuseppe Verdi, senza libero respiro e rasserenato, l’apparente via di fuga insomma dell’atto francese. Una possanza claustrofobica che il geniale Verdi, ottimo sceneggiatore di trame, non poteva aver calcolato, anche se continuasse per tutta la vita a rimescolare le versioni, dimostra che non era poi così realmente entusiasta della versione mutilata.

Un sacrificio psicologico che snatura i protagonisti e li decapa via di quella velatura onirica quasi ipnotica che li conferiva alla fisionomia di personaggi.
Quel sogno d’amore che Filippo sottrarrà a loro per ragioni di Stato, sostituendosi al promesso Carlo e che i due amanti impossibili continuano a proiettare in un irreperibile futuro.

Don Carlos polverizzato da un marchingegno inflessibile, nella nuova versione non ha spazio per un amore rilassato, tale che l’unico vero duetto d’amore paradossale è quello suo con Rodrigo, l’amico che ha deciso di coprire, proteggere questo “colpevole amore”.
Davvero la felicità non può esistere, nell’opera lirica, e che dramma sarebbe, altrimenti, si chiedono spesso i melomani.


Nella versione ridotta è vero, galleggiano riferimenti musicali che risultano però perduti alla deriva, vani anche alla luce della drammaturgia, tale che gli stessi personaggi risultano assottigliati, dimidiati nel loro spessore psicologico.
Elisabetta, la figlia di Caterina de’ Medici, che la storia ha tramandato come una donna caparbia e volitiva, qui risulta più algida, distante e ferita.

Lo stesso esitante Carlo ha una sua credibilità regale, nell’atto poi sacrificato: offre, incendiandosi nobilmente, di quell’amore che in seguito verrà bollato come incestuoso, dal mutare volubile della realpolitik.
In questo contesto che vien meno anche il breve interludio di Francia, quella vaga fiammella del casto, legittimo amore, di quell’idillio di “provato” miraggio che perseguiterà i due amanti segreti per tutta l’opera.


Don Carlos perde così ulteriormente una velatura di questa sua non identità di protagonista mancato, quasi “castrato”, tale che Giuseppe Verdi sente il bisogno di fargli comparire qualche “angiol consolator” la voce rassicurante del Marchese di Posa, Rodrigo, personaggio immaginario creato da Schiller, per introdurre il tema rivoltoso delle Fiandre in tensione.

Unica possibilità di riscatto per un personaggio come Don Carlos, che ha già “perduto” all’apertura di sipario, e che Rodrigo si fa sacello del suo dolore “Versami in cor il tuo strazio crudele”, un verso travasato d’affetti, che lo aiuta a incontrare la “madre” per l’ultima volta, che trama per lui all’insaputa del Re, per poi convincerlo a partire per cancellare quell’amore ormai dannato.
E non poco s’è ragionato sulla curiosa natura, anche musicale, di questo inconsueto legame fraterno, tenorile e baritonale, che i due si giurano e soprattutto cantano a voce finalmente a voce dispiegata in un memorabile duetto, l’unico davvero “sfogato” dell’opera.

Tutti in fondo perdono, in questa scura tragedia: con Filippo, vero despota della solitudine, naufraga l’illusione di poter essere amati “ Ella giammai m’amò” e di fronte al Grande Inquisitore si piega al suo potere di monarca; Elisabetta perde la patria lontana e l’amore puro per Carlos, la stima del Re e la dignità di Regina; la principessa di Eboli, che è il vero motore dell’intreccio perde l’amore di Elisabetta ed è costretta all’esilio; la dama di compagnia viene scacciata e Rodrigo perisce tragicamente.

Così la vera figura neutra, praticamente assente e vuota, non può nemmeno morire da martire: è Don Carlos, che l’ombra di Carlo V scende dal cielo a “rapire” verso le terre invisibili della finzione “Carlo V trascina nel chiostro Carlo smarrito”, che anche questa occasione dà soltanto il destro ai librettisti di far entrare in scena un deus es machina spettacolare, un Commendatore buono, non quello demoniaco nel Don Giovanni di Mozart.


Un grande terribile sogno decandentisco questo Don Carlos che ha aperto la stagione 2023-2024 del Teatro alla Scala con il trionfo della regia di Lluis Pasqual, delle scene Daniel Bianco e dei costumi fastosi di Franca Squarciapino, che ci suggeriscono ancora una volta la didascalia di quel lamento barocco in “Ella giammai m’amò” che va pronunciato quasi come sotto trance. Per questo, forse, tutta l’opera va letta e ascoltata come un magnifico incubo, che dà pace e felicità.
Di Alberto Corrado